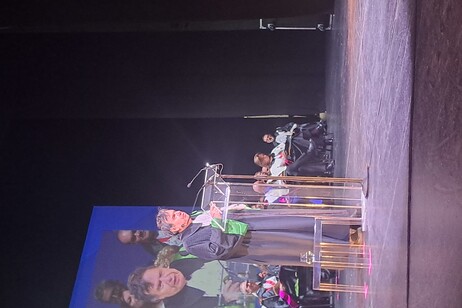Siamo a un bivio cruciale nell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, un momento storico che riecheggia l’alba della rivoluzione industriale.
Come alla fine del Settecento, quando le prime locomotive e le macchine a vapore irrompevano nel panorama tecnologico senza che la termodinamica, la scienza che ne governava il funzionamento, fosse ancora definita, oggi ci troviamo di fronte a sistemi di IA sempre più sofisticati, la cui comprensione profonda e il controllo razionale rimangono sfidanti.
Questa analogia, delineata con perspicacia da Giorgio Parisi, emerito professore alla Sapienza e Premio Nobel per la Fisica, durante la sua lectio magistralis all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, invita a una riflessione complessa sul percorso che ci attende.
Parisi, ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno portato all’attuale scenario – dai pionieristici studi di Camillo Golgi sulla struttura neuronale, passando per l’invenzione dei primi calcolatori e delle fotocamere digitali fino all’esplosione delle reti neurali e degli algoritmi di machine learning – ha evidenziato una lacuna critica: la mancanza di un quadro teorico unificante, un insieme di principi fondamentali che possano spiegare e prevedere il comportamento dei sistemi di IA complessi.
Non si tratta semplicemente di ottimizzare algoritmi o di aumentare la potenza di calcolo; si tratta di comprendere i meccanismi intrinseci che guidano l’apprendimento, la generalizzazione e la capacità di ragionamento delle macchine.
Questa mancanza, secondo Parisi, rappresenta una sfida primariamente rivolta alla comunità scientifica, in particolare ai fisici, chiamati a sviluppare nuovi strumenti concettuali e metodologici per affrontare questa complessità.
L’analogia con la termodinamica non è casuale.
La termodinamica, nata dalla necessità di comprendere e controllare l’energia prodotta dalle macchine a vapore, ha fornito una base scientifica solida per l’ingegneria, permettendo di ottimizzare l’efficienza, prevedere i limiti e garantire la sicurezza.
Analogamente, una “termodinamica dell’IA” potrebbe consentire di comprendere meglio i bias, le vulnerabilità e le implicazioni etiche di questi sistemi, promuovendo un’evoluzione più responsabile e sostenibile.
Potrebbe rivelare, ad esempio, come l’efficienza nell’apprendimento sia legata a vincoli energetici intrinseci, o come la generalizzazione dipenda dalla capacità di estrarre informazioni significative da set di dati limitati, in maniera analoga a come un motore a vapore efficiente massimizzi il lavoro utile minimizzando le perdite di calore.
L’intervento del Rettore Alessandro Reali ha ampliato la prospettiva, sottolineando il ruolo cruciale dell’Università di Pavia come fulcro di innovazione e collaborazione.
Riconoscendo il potenziale dell’Ateneo pavese, il Rettore ha insistito sulla necessità di una stretta integrazione con le risorse territoriali, a partire dal sistema di collegi, un patrimonio culturale unico in Italia, e dalla presenza di istituzioni di eccellenza come gli IRCCS, gli IUSS, il CNR, l’INFN, il CNAO, l’Eucentre, ChipsIT e un florido tessuto di fondazioni e aziende.
Questa visione sinergica, che vede l’Università come un motore di sviluppo locale e un partner strategico per il settore privato, si rivela essenziale per affrontare le sfide dell’era dell’IA, dove la competizione globale richiede competenze multidisciplinari e una capacità di trasformare la ricerca in soluzioni concrete.
L’Università non è più un’isola di sapere, ma un nodo centrale in una rete di collaborazione e innovazione.