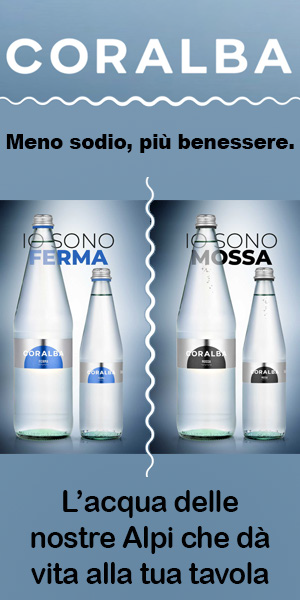La scoperta, a distanza di decenni, di un paio di sci Rossignol, un Omega e una moneta del 1949 incastonati tra i ghiacciai del Cervino, ha acceso una luce nuova sulla storia dell’identificazione personale, un’indagine che è molto più di un semplice recupero di un’identità perduta.
L’evento, al centro del saggio “Tracce di Memoria: L’Identità tra Scienza e Storia Criminale” (Le Lucerne, 2025), di Mirella Gherardi, medico legale di Aosta, si rivela un nodo cruciale in un percorso multidisciplinare che abbraccia medicina legale, criminologia, storia sociale e letteraria.
L’identificazione, lungi dall’essere una procedura scientifica moderna, affonda le sue radici in una complessa evoluzione culturale e sociale.
Il libro di Gherardi ricostruisce questo cammino, a partire dalle prime, rudimentali tecniche di riconoscimento utilizzate per distinguere un ladro in una folla, fino alle sofisticate analisi del DNA contemporanee.
L’alba della criminologia moderna vede la figura di Eugène Vidocq, ex-criminale che, ironia della sorte, fondò la prima agenzia di investigazioni di Parigi.
La sua abilità nell’osservare dettagli apparentemente insignificanti – una cicatrice, un tatuaggio, un segno particolare – rivoluzionò il metodo di identificazione, trasformando l’esperienza criminale in strumento di contrasto.
Successivamente, Alphonse Bertillon introduce il sistema antropometrico, una serie di misure del corpo umano che, con l’iconico “mug shot”, mirava a creare un archivio univoco per ogni individuo.
Un sistema che, sebbene innovativo, si rivelò vulnerabile all’inganno e alla somiglianza fisica.
Il passaggio cruciale verso un’identificazione più affidabile avviene con la riscoperta e l’applicazione scientifica delle impronte digitali.
Un’innovazione nata in India, esportata in Gran Bretagna e adottata in Argentina da Juan Vucetich, che ne sfruttò le potenzialità per risolvere un caso di omicidio, segnando un punto di svolta nella storia forense.
Il ventesimo secolo assiste all’avvento della genetica, con la progressiva applicazione di test biologici e analisi del DNA che riaprono vecchi misteri e restituiscono dignità a vittime dimenticate.
Ma l’identificazione non è solo scienza: è anche politica, giustizia, memoria collettiva.
Il libro di Gherardi intreccia le indagini scientifiche con eventi storici emblematici: l’Affaire Dreyfus, che mise a nudo pregiudizi e errori giudiziari; il furto della Gioconda, che sollevò interrogativi sulla natura dell’arte e della proprietà; gli orrori di Jack lo Squartatore, che alimentarono il mito del serial killer; il delitto Matteotti, simbolo della violenza politica; la battaglia legale di Charlie Chaplin per affermare la sua paternità, dimostrando come l’identità possa essere oggetto di contesa e manipolazione.
“Tracce di Memoria” non è solo la storia di come abbiamo imparato a identificare le persone, ma anche una riflessione profonda sul significato dell’identità stessa, un costrutto fragile e complesso, continuamente messo in discussione dalla scienza, dalla giustizia e dalla memoria del mondo.
La scoperta sui ghiacciai del Cervino, in questo senso, rappresenta un monito: l’identità, come il ghiaccio eterno, può rimanere nascosta per secoli, ma la sua riscoperta è sempre una sfida che ci invita a confrontarci con il passato e a interrogarci sul futuro.