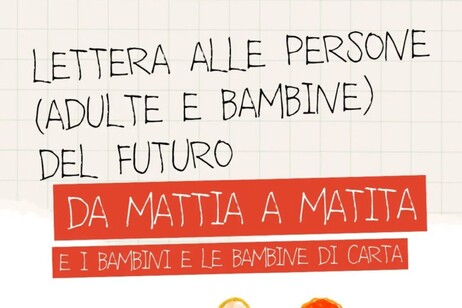Il temporale del 15 settembre 2022, una ferita aperta nel tessuto delle Marche, non si è limitato a scatenare un’alluvione.
È stato il tragico epilogo di una catena di eventi e omissioni, un monito doloroso sulle fragilità del nostro rapporto con il territorio e sulla responsabilità collettiva che ne consegue.
La scomparsa di Mattia, un bambino di otto anni strappato alla vita dalla furia delle acque, incarna la tragedia di un’intera comunità, ma anche la denuncia silenziosa di un sistema che non riesce a proteggere i più vulnerabili.
L’evento catastrofico, concentrato nelle valli del Misa e del Nevola, ha colpito duramente i comuni di Barbara e Ostra, lasciando dietro di sé tredici vittime e un paesaggio irrimediabilmente segnato.
Ma oltre alla devastazione materiale, si rivela una complessa rete di fattori che hanno amplificato l’impatto disastroso.
Non si tratta semplicemente di una questione meteorologica.
Il pluviometro ha registrato precipitazioni eccezionali, certo, ma la loro trasformazione in morte e distruzione è stata accelerata da decenni di interventi antropici che hanno alterato profondamente l’equilibrio naturale.
L’abusivismo edilizio, l’urbanizzazione selvaggia, la cementificazione spietata dei corsi d’acqua e l’assenza di una pianificazione territoriale oculata hanno creato un ambiente impermeabile, incapace di assorbire le acque meteoriche.
I torrenti, un tempo rigogliosi corridoi ecologici, sono stati ridotti a canali artificiali, privi di vegetazione ripariale e con la capacità di deflusione drasticamente compromessa.
Le arginature, spesso realizzate in modo inadeguato o addirittura dannose, hanno innalzato il livello dell’acqua, intensificando l’effetto di inondazione.
La perdita di Mattia, e con lui la speranza di un futuro, non è solo una tragedia personale, ma anche un fallimento sociale.
È il risultato di una miopia collettiva, di scelte politiche che hanno anteposto interessi economici a considerazioni ambientali e di sicurezza.
È un campanello d’allarme che invita a una profonda riflessione sulla nostra responsabilità verso il territorio che ci ospita e verso le generazioni future.
La ricostruzione non deve limitarsi a riparare i danni materiali, ma deve essere un’opportunità per ripensare il nostro modo di vivere e di interagire con l’ambiente.
È necessario un cambio di paradigma, che ponga al centro la sostenibilità, la resilienza e la protezione dei più deboli.
È imperativo investire in sistemi di monitoraggio e allerta precoce, in infrastrutture verdi, in una pianificazione territoriale partecipata e in una cultura della prevenzione.
Solo così potremo onorare la memoria di Mattia e delle altre vittime, trasformando la loro scomparsa in un impegno concreto per un futuro più sicuro e più giusto.
La terra, umiliata e ferita, attende che impariamo a rispettarla e a proteggerla, prima che sia troppo tardi.