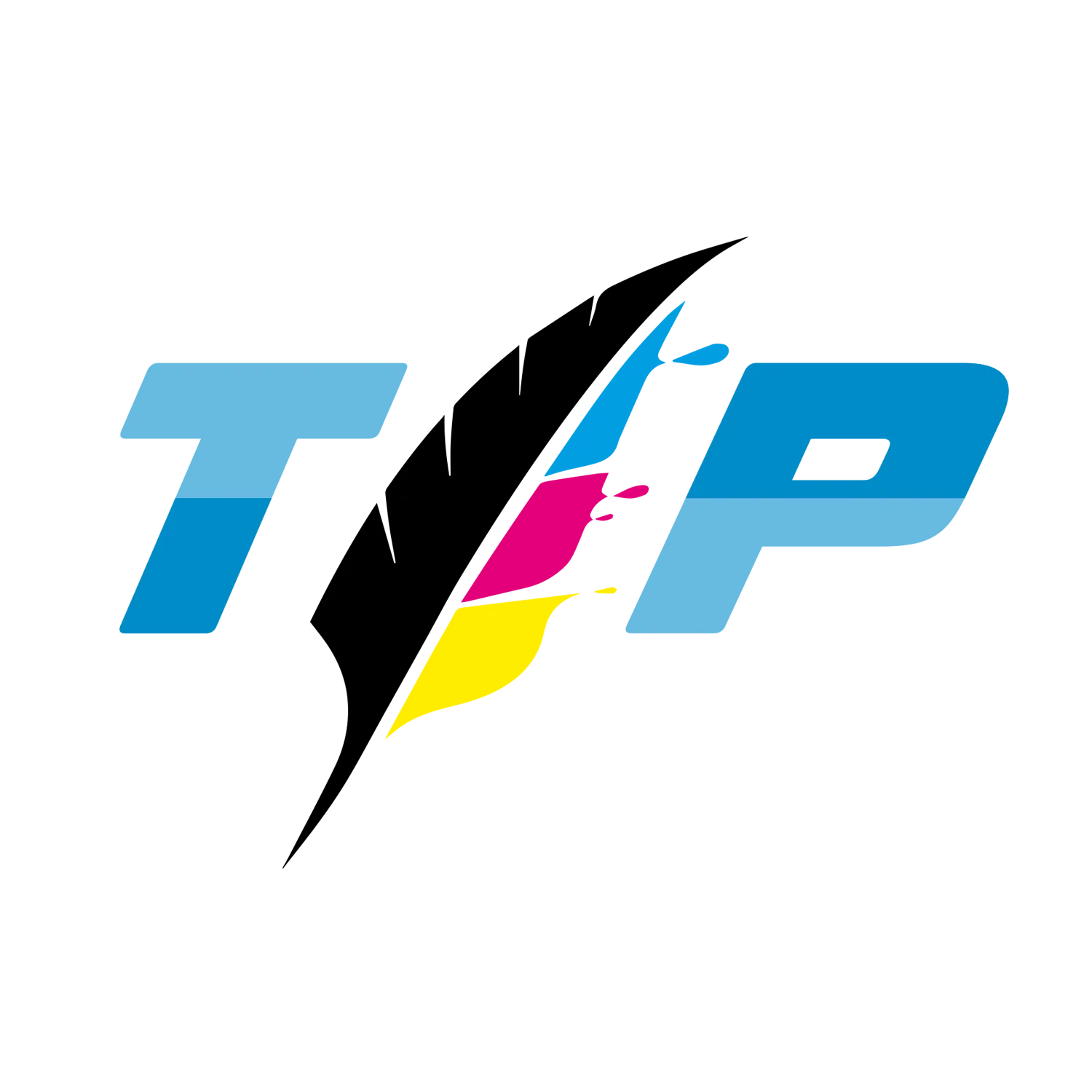Rimettere in discussione le narrative di “crisi”: un approccio antropologico per decostruire le emergenze climatiche e migratorie.
Questo è il cuore del dialogo svoltosi al Borarium di Opicina, spazio nefasto eppure illuminante del Museo della Bora, inaugurato con l’evento “Brutto tempo: migrazioni e climate change”.
L’incontro, concepito come un tassello del più ampio progetto DIMEast – un’indagine antropologica sui confini orientali dell’Europa finanziata dall’Unione Europea attraverso il PNRR – ha invitato a un esame critico delle nostre assunzioni e a una revisione dei modelli interpretativi che tendono a presentare i fenomeni climatici estremi e i flussi migratori come eventi eccezionali, singolari, che interrompono un’apparente normalità.
La professoressa Roberta Altin, antropologa culturale di spicco presso l’Università di Trieste, ha lanciato una sfida radicale: la stigmatizzazione di questi processi come “crisi” rischia di paralizzarci, di relegarli in una dimensione di urgenza transitoria, impedendo un’effettiva presa di coscienza e l’adozione di pratiche di adattamento e resilienza a lungo termine.
L’allarme, ripetuto incessantemente, produce anestesia cognitiva.
L’innovazione concettuale portata avanti dall’assegnista di ricerca Giuseppe Grimaldi ha ulteriormente inasprito la riflessione.
Grimaldi propone di considerare il clima non come sfondo neutro o elemento passivo, ma come un “dispositivo di frontiera”, un elemento attivo nella costruzione e nel mantenimento dei confini geopolitici ed economici.
Il freddo, la neve, le ondate di calore non sono semplici fattori ambientali, ma strumenti di controllo, barriere fisiche e simboliche che plasmano l’esperienza migratoria, rendendola più pericolosa e traumatica.
La tragica scomparsa di quattro migranti tra Trieste, Udine e Pordenone, vittime del freddo pungente, non può essere liquidata come un evento sfortunato.
Al contrario, rappresenta una manifestazione concreta di un sistema di frontiera spietato, in cui la natura è manipolata e trasformata in arma.
Le testimonianze raccolte, angoscianti e sconcertanti, rivelano pratiche deliberatamente disumane: guardie di frontiera che confiscarebbero le scarpe ai migranti, costringendoli a ripercorrere a piedi percorsi insidiosi e privi di protezione, esponendoli a ferite, infezioni e, in ultima analisi, alla morte.
La privazione di un semplice paio di scarpe si traduce in una condanna a soffrire, a indebolirsi, a perdere ogni speranza.
La riflessione sollevata da questi elementi ci obbliga a riconsiderare le nostre responsabilità.
Non possiamo limitarci a deplorare le tragedie, ma dobbiamo agire per smantellare le strutture di potere che le rendono possibili.
È necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolga antropologi, climatologi, economisti, politici e, soprattutto, le voci dei migranti stessi, per comprendere appieno la complessità di questi fenomeni e per costruire un futuro più giusto e sostenibile, in cui il clima non sia un dispositivo di esclusione, ma un elemento di connessione e di condivisione.
Il Borarium, con la sua storia di vento e di isolamento, si erge come un monito e un invito a superare i confini, sia quelli geografici che quelli mentali, per abbracciare un’umanità più ampia e consapevole.