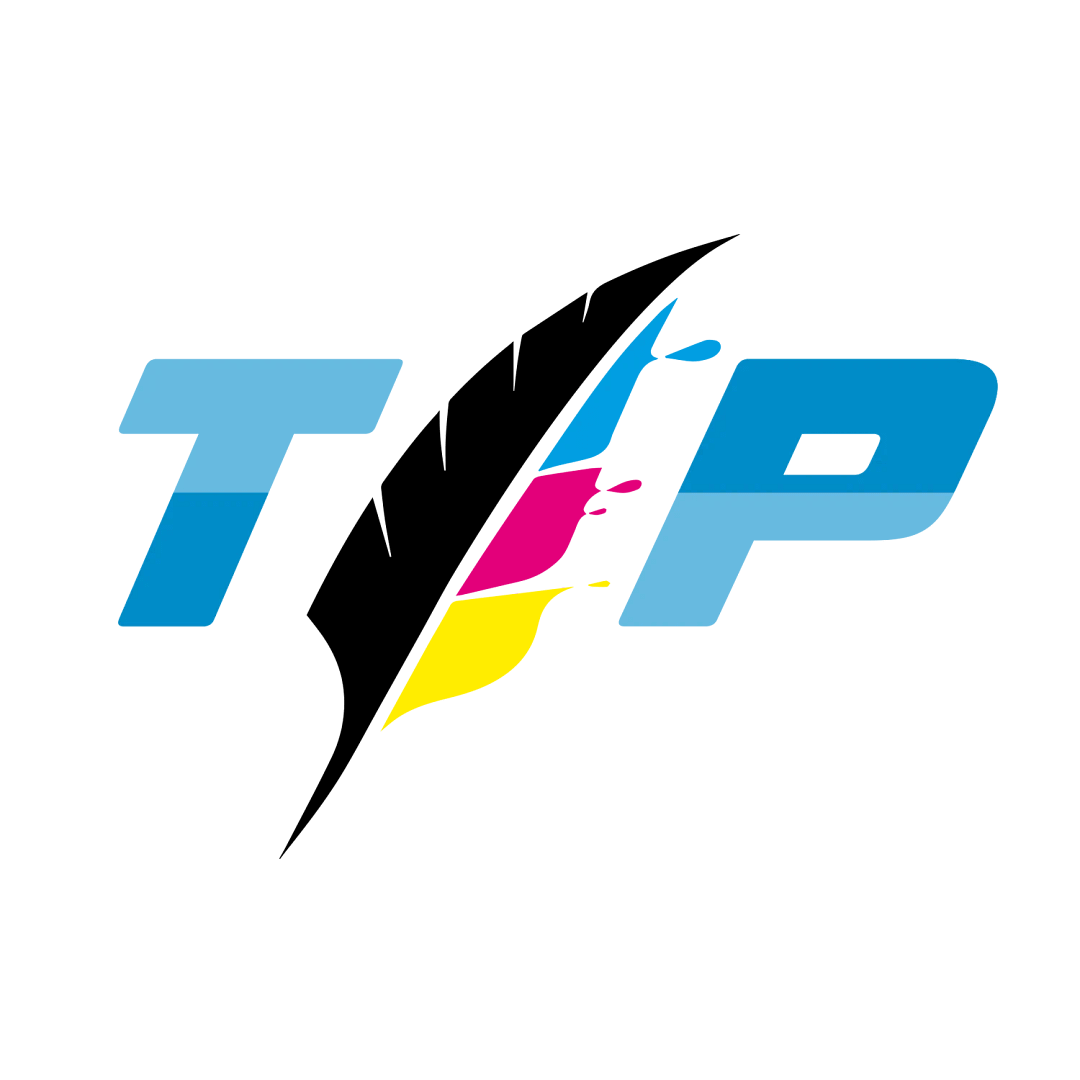La Sardegna si confronta con una prevalenza di sintomi depressivi significativi, collocandola tra le regioni italiane con un quadro di disagio psicologico rilevante.
Tuttavia, un segnale di speranza emerge dai recenti dati del Rapporto sulla Salute Mentale, che segnala un incremento notevole nell’accesso ai Servizi Pubblici per il trattamento della depressione.
L’aumento, passato da 10,5 a 37,5 trattamenti per 10.000 abitanti tra il 2022 e il 2023, porta l’isola a raggiungere la media nazionale di 36,5 per 10.000 abitanti, evidenziando una potenziale evoluzione nel sistema di cura.
Questa variazione, come sottolinea la Dottoressa Pinna, potrebbe riflettere non solo una crescente capacità del sistema sanitario di identificare precocemente il disagio psichico, ma anche una progressiva diminuzione dello stigma associato alle malattie mentali, incoraggiando un numero maggiore di persone a cercare aiuto professionale.
La maggiore disponibilità a richiedere supporto, tuttavia, non si traduce ancora in una risposta adeguata per tutti coloro che soffrono.
Nonostante i progressi, una parte considerevole dei sardi affetti da depressione, stimati in circa 145.000 individui, pari al 10,1% degli adulti e al 12,3% degli anziani, non riceve una diagnosi precisa né un trattamento efficace.
Questa lacuna sottolinea la necessità di un’azione più incisiva e di un’allocazione di risorse più mirata.
Diversi fattori sociali ed economici contribuiscono all’aumento del rischio di depressione in Sardegna.
La profonda incidenza della povertà, l’elevata disoccupazione, l’isolamento geografico e sociale, gli eventi traumatici della vita e la presenza di patologie fisiche croniche creano un terreno fertile per lo sviluppo del disturbo.
Le donne e gli anziani rimangono le categorie più vulnerabili, ma si registra un preoccupante aumento dei casi anche tra i giovani, un fenomeno amplificato dalla recente esperienza pandemica e dalle sue conseguenze socio-psicologiche.
Le strategie terapeutiche impiegate, come evidenzia il Professor Manchia, includono l’uso di farmaci antidepressivi, che richiedono una competenza specialistica nella gestione clinica, spesso integrati con psicoterapia e terapie biologiche complementari, come la stimolazione magnetica transcranica.
Tuttavia, una significativa porzione di pazienti (circa un terzo) manifesta resistenza ai trattamenti convenzionali, richiedendo interventi innovativi.
L’esplorazione di nuove opzioni terapeutiche, come i farmaci a rapida azione (esketamina) o approcci sperimentali che coinvolgono la psilocibina, si rivela quindi cruciale per migliorare i risultati clinici.
La depressione, a livello globale, rappresenta una delle principali cause di disabilità, impatto sociale e costi sanitari, ed è una delle motivazioni primarie per l’accesso ai servizi di salute mentale.
Oltre 322 milioni di persone nel mondo ne soffrono, mentre in Italia, nel biennio 2022-2023, più di 3,5 milioni di individui hanno riferito sintomi depressivi, con un impatto tangibile sul loro benessere psicologico.
Il rischio aumenta con l’età, raggiungendo il picco tra i 55 e i 64 anni, ed è più elevato tra le donne, le persone socialmente svantaggiate, coloro che vivono in solitudine e coloro che mancano di una solida rete di supporto.
Per affrontare efficacemente questa sfida, è imperativo un rafforzamento significativo dei servizi territoriali di salute mentale.
Ciò implica non solo un aumento delle risorse finanziarie, ma anche un investimento in percorsi di presa in carico personalizzati, con l’obiettivo di garantire un accesso tempestivo, continuità terapeutica e un’assistenza di qualità a ogni individuo che lotta contro la depressione.
Inoltre, campagne di sensibilizzazione mirate possono contribuire a ridurre lo stigma e promuovere una cultura della prevenzione e del benessere psicologico, elementi cruciali per costruire una comunità più resiliente e inclusiva.