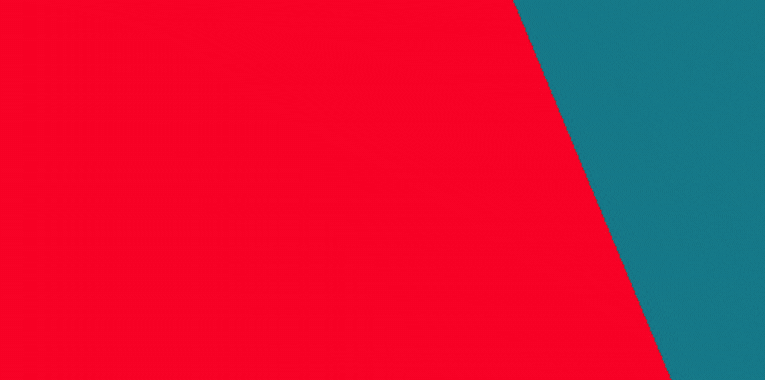La decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di destinare 1,4 milioni di euro a iniziative celebrative di figure di spicco della storia italiana solleva interrogativi profondi e innesca un acceso dibattito, particolarmente sentito in Alto Adige.
La presenza di Giovanni Gentile, filosofo e ministro dell’Istruzione durante il regime fascista, nell’elenco dei destinatari di tale riconoscimento, come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, appare, a detta della senatrice Julia Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie e portavoce della Südtiroler Volkspartei (SVP), non solo inopportuna, ma profondamente lesiva.
La controversia si inserisce in un contesto storico già segnato da polemiche, come quella del precedente anno relativa all’emissione di un francobollo celebrativo, evidenziando una persistente difficoltà nel discernere tra la necessità di una riflessione storica complessa e la celebrazione acritica di figure legate a un regime totalitario.
L’azione di Gentile, e in particolare la sua riforma scolastica, si configurò come uno strumento cruciale nell’attuazione di una politica di italianizzazione forzata, particolarmente aggressiva nei confronti del Sudtirolo.
La proibizione dell’uso della lingua tedesca nelle scuole, imposta con rigore, rappresentò un trauma profondo per la comunità altoatesina, strappando bambini e ragazzi al diritto fondamentale di apprendere nella propria lingua madre.
Questa decisione, oltre a negare un diritto inalienabile, mirava a cancellare l’identità culturale e linguistica di una popolazione.
La risposta corale della comunità altoatesina si concretizzò nella creazione delle “Katakombenschulen”, scuole clandestine gestite in gran parte da donne che, con coraggio e determinazione, continuarono a insegnare il tedesco in segreto.
Questo atto di resistenza, compiuto in condizioni di estrema precarietà e sotto costante pericolo di arresto, testimonia la profonda resilienza e l’attaccamento alla propria identità culturale.
Molte di queste donne subirono persecuzioni, detenzione e, in alcuni casi, persero la vita nelle carceri fasciste, pagando con la propria esistenza il diritto di preservare la lingua e la cultura altoatesina.
È innegabile che la figura di Gentile presenti aspetti complessi e meriti un’analisi storiografica approfondita.
Tuttavia, la distinzione tra un’indagine critica e una celebrazione pubblica, soprattutto in un contesto di riconoscimento istituzionale, appare imprescindibile.
Includere un personaggio chiave nella macchina repressiva del regime fascista tra gli “italiani illustri” si configura come un affronto diretto non solo alla comunità altoatesina, ma a tutte le vittime del fascismo, e rischia di banalizzare le sofferenze e le ingiustizie subite.
La vicenda solleva, quindi, interrogativi fondamentali sul ruolo della memoria e sulla responsabilità dello Stato nel promuovere una narrazione storica inclusiva e rispettosa delle diverse identità che compongono il tessuto nazionale.