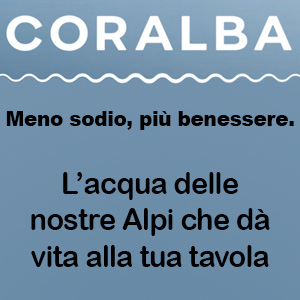Il 23 maggio 1992 si è impresso nella coscienza italiana come un giorno di lutto profondo, un varco nell’ordinario che ha rivelato l’abisso della mafia e la sua spietata volontà di distruggere lo Stato di diritto. La strage di Capaci, un attentato di proporzioni inaudite, ha segnato la scomparsa del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, un’ecatombe che ha scosso la nazione fino alle sue fondamenta.L’attentato, premeditato e meticolosamente pianificato, si è consumato sull’autostrada A29, nei pressi di Capaci, in provincia di Palermo. Giovanni Brusca, soprannominato “u zoom”, da una posizione privilegiata, un punto di osservazione strategicamente scelto che dominava il luogo dell’orrore, diede l’ordine di far detonare i cinquecento chili di esplosivo che avevano trasformato un tratto di autostrada in una trappola mortale. La preparazione dell’ordigno, opera dell’esperto artificiere Pietro Rampulla, fu caratterizzata da una precisione inquietante. Il tritolo, accuratamente dosato e posizionato sotto un tunnel, avrebbe proiettato l’auto blindata di Falcone in aria, in un vortice di detriti e morte. La dinamica dell’esplosione, amplificata dalla forma del tunnel, generò un’onda d’urto devastante, che neutralizzò ogni possibilità di sopravvivenza per le persone presenti nell’auto e nelle immediate vicinanze.Oltre al giudice Falcone, la strage di Capaci strappò alla vita Francesca Morvillo, sua moglie e collega magistrato, un’intellettuale impegnata nella lotta alla criminalità organizzata. A loro si unirono gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, figure dedite a proteggere il magistrato, che persero la vita compiendo il loro dovere. Giuseppe Costanza, l’autista della scorta, fu l’unico sopravvissuto, testimone indiscusso di una tragedia immane.La strage di Capaci non fu un atto isolato, ma la conclusione di una strategia di eliminazione mirata ai principali artefici della lotta alla mafia. Preceduta dalla strage di Via D’Amelio a Palermo, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la strage di Capaci rappresentò l’apice di una guerra impari contro lo Stato. L’attentato mise in luce la capacità della mafia di penetrare nelle istituzioni, di corrompere e di manipolare il potere, e di sfidare apertamente le leggi.La memoria della strage di Capaci, insieme a quella di tutte le vittime della mafia, continua a essere un monito costante per la società italiana, un invito a non dimenticare e a combattere con determinazione la criminalità organizzata, preservando i valori della legalità, della giustizia e della libertà. La lotta contro la mafia è una responsabilità collettiva, un impegno che richiede vigilanza, coraggio e un’incrollabile fiducia nelle istituzioni democratiche.
EDIZIONI LOCALI
Nessun risultato trovato.
- Pubblicità -

Ponte sullo Stretto: Legalità e Sviluppo, una Sfida Complessa
In un contesto politico e sociale caratterizzato da una crescente sensibilità verso la criminalità organizzata, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina assume...
Cannes 2024: Trionfo uruguaiano e sostegno al cinema palestinese
Il Festival di Cannes 2024 ha visto l'assegnazione del Premio della sezione "Un Certain Regard", un riconoscimento destinato a opere cinematografiche che si discostano...
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 23 maggio
(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 23 maggio 2025. Centrati invece trentanove '5' che vincono 3.118,11...
Carlo Conti: Sanremo, Rai e il Futuro tra Innovazione e Ricambio
Carlo Conti: Tra Sanremo, Innovazione e il Ricambio Generazionale nella RaiDogliani, cuore pulsante delle Langhe, ha ospitato l'atto iniziale del Festival della Tv, un...
Gasperini-Atalanta: un futuro da definire, tra storia e ambizioni.
Il futuro dell'Atalanta, e di Gian Piero Gasperini al suo timone, si configura come un crocevia complesso, intriso di storia, ambizioni e una profonda...
- Pubblicità -
Brissogne: Senatori M5S chiedono indagine urgente sulla casa circondariale
L'urgenza di un'indagine approfondita sulla gestione della casa circondariale di Brissogne ha spinto un gruppo di senatori del Movimento 5 Stelle – Pirro, Lopreiato,...
Nuova Piscina Pré-Saint-Didier: Apertura a Luglio 2025, Tra Speranze e Dubbi
L'imminente apertura della rinnovata piscina di Pré-Saint-Didier, attualmente fissata per luglio 2025, rappresenta un punto di svolta atteso con ansia da parte della comunità...
Procura Corte Conti: nuovo processo contro 16 imputati per aiuti di Stato illegali a favore allevatori valdostani
E' stata fissata per il prossimo 29 ottobre la nuova udienza davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del processo contabile contro 16...
Sette arresti per i mandanti del traffico di droga in Valle d’Aosta.
La polizia ha condotto un'operazione mirata contro il traffico di stupefacenti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, che si è conclusa con l'emissione di...
- Pubblicità -

Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.