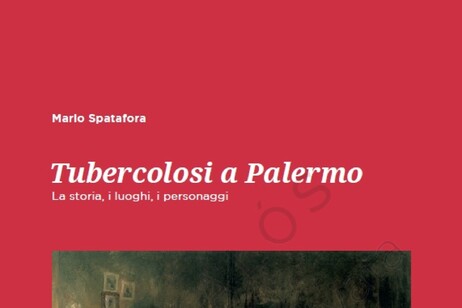Tubercolosi a Palermo: Un Mosaico di Vite, Sofferenza e ResilienzaLa tubercolosi, flagello silenzioso che affligge l’umanità, persiste come una delle principali cause di decesso a livello globale.
Un dato statistico impietoso – milioni di nuove infezioni e centinaia di migliaia di morti ogni anno – sottolinea la sua persistente rilevanza e la necessità di un approccio che vada oltre la semplice emergenza sanitaria, abbracciando le intricate dinamiche sociali e culturali che ne determinano la diffusione.
“Tubercolosi a Palermo”, l’opera di Mario Spatafora, medico pneumologo palermitano, si configura come un’indagine profonda e commovente su questa realtà, intrecciando la storia di una malattia con quella di una città, tra Ottocento e Dopoguerra.
Il libro non si limita a tracciare l’evoluzione clinica e terapeutica della tubercolosi, ma ne restituisce l’impatto sulla società palermitana, svelando un universo di dolore, speranza e straordinaria resilienza.
Spatafora, attraverso una meticolosa ricerca d’archivio e testimonianze dirette, ci introduce a un mondo dimenticato, abitato da pazienti, medici, filantropi e figure emblematiche che hanno segnato la storia della città.
Dalle famiglie aristocratiche, come i Florio, ai bambini provenienti dai quartieri più degradati, la tubercolosi ha colpito indiscriminatamente, scavando solchi profondi nel tessuto sociale.
Un’immagine vivida di questa realtà ci viene offerta dalla figura di Gesualdo Bufalino, il futuro scrittore che, durante la sua permanenza presso il sanatorio della Rocca, trovò ispirazione per il suo capolavoro, “Diceria dell’untore”.
Il libro svela storie di straordinario impegno umano, come quella di Giulia Alliata di Montereale, la principessa che, pur vivendo nel lusso del palazzo Valguarnera (lo sfondo del celebre ballo del Gattopardo), dedicò la sua vita alla cura dei bambini malati attraverso la “Casa del Sole”.
Parallelamente, emerge la figura di Vincenzo Cervello, pioniere nel campo della filantropia medica, creatore del secondo sanatorio popolare italiano.
Il panorama istituzionale dell’epoca era costellato da centri antitubercolari, tra cui lo Spasimo del quartiere Kalsa, un luogo dove la sofferenza si manifestava in forme a volte drammatiche.
L’episodio delle 83 donne ricoverate nel 1934, di cui 34 morirono e 49 si dimisero volontariamente per problemi disciplinari, offre uno spaccato crudo delle condizioni di vita e delle difficoltà incontrate dai pazienti.
Le dimissioni forzate, oltre a rappresentare una sanzione severa, esacerbavano le condizioni del malato e della sua famiglia, generando un circolo vizioso di povertà e disperazione.
La ricerca di comfort e la frustrazione nei confronti della rigidità delle istituzioni generavano, come inevitabile conseguenza, fenomeni di illegalità e traffici occulti, creando un sottobosco di miseria e degradazione morale.
“Tubercolosi a Palermo” non è solo un resoconto storico, ma anche una riflessione sulla condizione umana, sulla capacità di resilienza e sulla necessità di affrontare le disuguaglianze sociali che alimentano la diffusione delle malattie.
Sebbene il mondo descritto nel libro appartenga a un’epoca passata, la tubercolosi rimane una sfida globale, che richiede un impegno continuo per la ricerca di nuove terapie e per la promozione di politiche sanitarie e sociali più eque e inclusive.
L’opera di Spatafora ci invita a non dimenticare il passato, per costruire un futuro in cui la salute sia un diritto universale e non un privilegio.