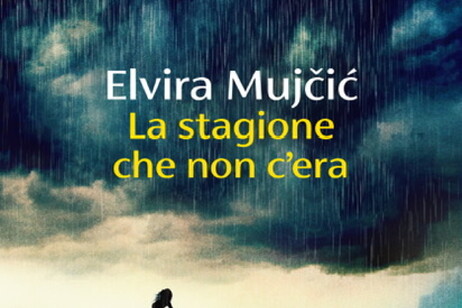L’eco di un’epoca perduta: memoria, identità e il peso del futuro in “La stagione che non c’era” di Elvira MujcicElvira Mujcic, voce narrante figlia di un’esperienza di esilio e memoria ferita, ci offre con il suo romanzo “La stagione che non c’era” (Guanda, 2024) una riflessione profonda e dolorosa sulla dissoluzione di un’identità nazionale, la Jugoslavia, e sulle conseguenze devastanti del risorgere di antichi rancori.
Il libro, pubblicato a trent’anni dal massacro di Srebrenica, non è una mera ricostruzione storica, ma un’indagine intima e universale sul potere della memoria, sulla fragilità dell’appartenenza e sulla difficoltà di costruire un futuro quando il passato si ripresenta come spettro minaccioso.
Mujcic, autrice di opere precedenti come “Dieci prugne ai fascisti” e “Consigli per essere un bravo immigrato”, si immerge in un 1990 jugoslavo sospeso tra la nostalgia per un’epoca di speranza e i primi, inquietanti segnali di un’imminente tragedia.
La Jugoslavia, terra di convivenza multietnica e di ideali socialisti, si incrina sotto il peso delle spinte nazionalistiche, alimentate da una retorica sempre più virulenta.
L’autrice, cresciuta in quel contesto e poi costretta all’esilio, evoca un’atmosfera elettrica, densa di presagi, in cui il futuro si tinge di incertezza.
Al centro del racconto troviamo Nene, un artista tormentato dalla paura che la sua Jugoslavia scompaia, cancellata dalla memoria collettiva.
Il suo desiderio ossessivo è quello di creare un’opera che testimoni il tempo vissuto dalla sua generazione, un atto di resistenza contro l’oblio.
Accanto a lui, Merima, giovane idealista animata da un profondo senso di responsabilità, si impegna a contrastare le spinte disgregatrici che minacciano l’unità nazionale, mentre cerca di lenire le cicatrici di una ferita amorosa che ha segnato la sua vita.
Questa ferita ha generato Eliza, la figlia di Merima, una bambina di otto anni nata in un contesto di conflitto e segnata dal silenzio su un padre che non ha mai conosciuto, vittima, come molti altri, delle nuove divisioni.
Il romanzo non si limita a descrivere un conflitto; esplora le complesse dinamiche psicologiche dei personaggi, le loro speranze, le loro paure, i loro rimpianti.
Mette in luce la difficoltà di conciliare il passato e il futuro, l’impossibilità di costruire un’identità stabile quando le radici sono profondamente ferite.
La “stagione che non c’era” non è solo un riferimento temporale, ma una metafora di un’epoca perduta, un’opportunità mancata, un sogno infranto.
È l’eco di un passato che continua a risuonare nel presente, un monito per il futuro.
Mujcic, con la sua scrittura intensa e commovente, ci invita a riflettere sul potere distruttivo dell’odio e sull’importanza di preservare la memoria come strumento di conoscenza e di riconciliazione.
Il suo lavoro, presentato in anteprima al Letterature Festival Internazionale di Roma, si configura come un contributo prezioso al dibattito sulla memoria collettiva e sulla necessità di costruire un futuro basato sul rispetto delle diversità e sulla riconciliazione.