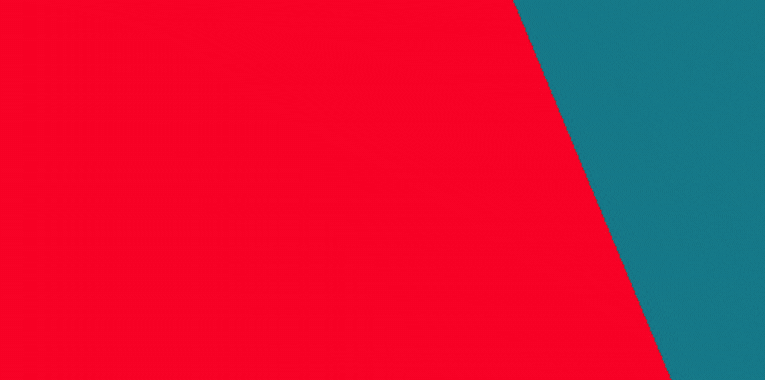La recente pubblicazione di un bando da 1,4 milioni di euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a progetti celebrativi di figure di spicco nella storia italiana, ha riacceso un acceso dibattito sulle modalità di commemorazione del passato e sui confini etici della celebrazione pubblica.
In particolare, l’inclusione di Giovanni Gentile, figura controversa e ministro dell’Istruzione durante il Ventennio fascista, ha suscitato profonda indignazione e solleva interrogativi cruciali sulla memoria storica e il rispetto per le minoranze linguistiche.
La scelta, come anticipato da fonti informative, appare particolarmente insensibile alla luce di precedenti episodi, come la polemica suscitata l’anno scorso dalla progettazione di un francobollo celebrativo, che avevano già evidenziato la delicatezza del tema.
La senatrice Julia Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie, ha espresso con fermezza il suo disappunto, sottolineando l’incongruenza di onorare una figura centrale nella realizzazione di una politica di italianizzazione forzata che ha avuto conseguenze devastanti sul territorio sudtirolese.
La riforma gentileana, più che una semplice riforma scolastica, rappresentò uno strumento ideologico volto all’assimilazione culturale e linguistica, con un impatto diretto e doloroso sulla comunità germanofona del Sudtirolo.
L’imposizione dell’italiano come unica lingua di insegnamento, con il divieto di utilizzo del tedesco, comportò la deprivazione di un intero segmento della popolazione dall’accesso alla propria lingua madre, un diritto fondamentale alla propria identità culturale.
Questo atto di oppressione linguistica diede origine a una rete clandestina di scuole, le cosiddette *Katakombenschulen*, luoghi di resistenza silenziosa dove insegnanti, prevalentemente donne, rischiando la propria libertà e la propria vita, mantennero viva la fiamma dell’istruzione in tedesco.
Queste donne, figure eroiche e spesso dimenticate, subirono persecuzioni, arresti e, in alcuni casi, la morte nelle carceri fasciste, incarnando la resilienza e la determinazione di un popolo che si rifiutava di rinunciare alla propria identità.
È innegabile che Giovanni Gentile rappresenti una figura complessa, meritevole di analisi storico-filosofica approfondite.
Il suo pensiero, che intreccia idealismo e pragmatismo, offre spunti di riflessione rilevanti per la comprensione del pensiero politico italiano del Novecento.
Tuttavia, sussiste una differenza abissale tra l’indagine storiografica, che mira alla comprensione critica del passato, e la celebrazione acritica, che rischia di banalizzare le sofferenze e le ingiustizie subite.
Includere una figura come Gentile in una lista di “italiani illustri” si configura non solo come una mancanza di sensibilità nei confronti della comunità sudtirolese, ma anche come un affronto alla memoria delle vittime del fascismo e un potenziale ostacolo alla costruzione di una memoria collettiva autentica e inclusiva.
La celebrazione del passato non dovrebbe mai prescindere da un’attenta riflessione etica e da un profondo rispetto per la dignità di ogni individuo e di ogni comunità.
Il dibattito sollevato da questa iniziativa rappresenta un’opportunità per riaffrontare il tema della memoria storica e per definire i limiti, imprescindibili, della celebrazione pubblica.