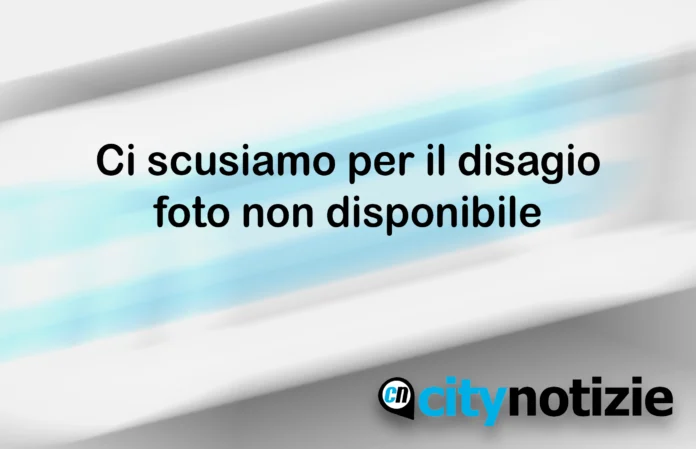La biografia di Insaf Dimassi incarna una riflessione profonda sull’appartenenza, l’identità e le fragilità del sistema di cittadinanza italiano. Nata in Tunisia e cresciuta in Italia fin dai nove mesi, la giovane donna si è trovata a confrontarsi, al raggiungimento della maggiore età, con una scelta cruciale: accelerare l’iter burocratico per ottenere la cittadinanza o investire nel proprio percorso di studi. La decisione, presa dopo un’attenta ponderazione, l’ha portata a optare per la formazione accademica, rimandando la richiesta di cittadinanza.La sua storia, raccontata in occasione di un evento dedicato ai referendum sulla cittadinanza, offre uno spaccato emblematico delle disparità che caratterizzano l’accesso alla cittadinanza, un diritto che dovrebbe essere universalmente garantito ma che, nella pratica, è spesso condizionato da fattori economici, legali e familiari. L’esperienza del padre, muratore emigrato dalla Tunisia, che ha potuto ottenere la cittadinanza solo dopo anni di lavoro e tassazione, contrasta con la sua esclusione, dovuta al temporaneo superamento della soglia di età per la trasmissione *jure sanguinis*. Questa peculiarità legale l’ha posta in una condizione paradossale: l’unica membro della sua famiglia a non essere pienamente riconosciuta come cittadina italiana, nonostante abbia vissuto e contribuito al Paese per quasi tre decenni.L’ulteriore complicazione derivante dal divorzio dei genitori ha aggravato la situazione, rendendo ancora più difficile il raggiungimento del requisito economico necessario per l’ottenimento della cittadinanza *iure matrimonio*. Questo ha amplificato la sua percezione di essere sospesa tra due mondi, figlia di due culture, ma pienamente appartenente né a una né all’altra. Insaf, oggi dottoranda in scienze politiche e aspirante accademica, incarna una generazione di giovani cresciuti in Italia, profondamente legati al Paese, ma esclusi dalla partecipazione democratica. La sua esperienza mette in luce la disuguaglianza nell’accesso ai diritti civili e politici, creando una frattura tra “cittadini di serie A”, che possono dare per scontato il diritto di voto e di partecipazione, e “cittadini di serie B”, costretti a vivere in una condizione di precarietà giuridica. La sua capacità di navigare tra arabo, francese e italiano, con un accento che la connette a entrambe le sue eredità culturali, è fonte di orgoglio e di ironia. La presa in giro affettuosa della nonna tunisina, che la invita a “tornare in Italia” o a “tornare nel tuo paese”, sottolinea la sua condizione liminale, la sua identità ibrida, la sua costante negoziazione tra due appartenenze. La sua storia non è solo una biografia personale, ma un invito a riflettere sulle politiche migratorie e sull’inclusione sociale, un appello a garantire a tutti i giovani come lei la possibilità di sentirsi pienamente parte della comunità italiana, senza dover scegliere tra identità e appartenenza. La sua esperienza mette in luce la necessità di un dibattito più ampio e inclusivo sulla cittadinanza, un diritto che dovrebbe essere un ponte, non un ostacolo, all’integrazione e alla partecipazione democratica.
EDIZIONI LOCALI
Nessun risultato trovato.

Squadra abruzzese vince il torneo della disputa ‘Dire e Contraddire’
22 maggio 2025 - 12:51
La squadra del Liceo G.D'Annunzio di Pescara, rappresentante con orgoglio il territorio abruzzese e quello del centro Italia, ha vinto...
Palermo apre il Museo dei due giustizieri: ripercorre la storia e l’opera di Falcone e Borsellino.
22 maggio 2025 - 14:41
Domani, in occasione del trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, apre le porte al pubblico il Museo del Presente Giovanni...
Manifestazione di Palermo: un tributo alla legalità e ai diritti, 30 anni dopo Capaci.
22 maggio 2025 - 14:51
Domani, presso il molo Trapani di Palermo, si svolgerà un'importante manifestazione per celebrare l'anniversario della tragedia di Capaci, evento traumatico...
Palermo, apre il Museo del Presente Falcone e Borsellino
22 maggio 2025 - 17:46
Il 23 maggio 2024, a distanza di trentatre anni dalla straziante strage di Capaci, Palermo inaugura il Museo del Presente...
Econo.Mia: Alfabetizzazione Finanziaria per Donne e Resilienza a Palermo
22 maggio 2025 - 18:06
L'alfabetizzazione finanziaria emerge oggi non come un mero optional, bensì come un pilastro fondamentale per la costruzione di una società...
- Pubblicità -
Valle d’Aosta: approvato 8 milioni di euro per gli interventi urgenti dopo l’alluvione del 16 aprile.
Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha ratificato all'unanimità un progetto di legge che prevede la concreta applicazione di trasferimenti straordinari e urgenti a...
Processo a un giovane verrezziese: da tentato omicidio a lesioni, aperta la strada alla messa in prova
Il processo contro Andrea Dorindo, un ventiduenne di Verrès, si è chiuso con una sorprendente svolta: la procura ha deciso di riqualificare il capo...
La École Hôtelière de la Vallée d’Aoste: scuola di formazione inclusiva nel settore turistico-alberghiero.
La École Hôtelière de la Vallée d'Aoste di Chatillon è una scuola di alta formazione nel settore turistico-alberghiero che, da anni, si distingue per...
La Giunta Regionale adotta delibera fondamentale sul finanziamento dei servizi per anziani: aumenti e nuove tariffe per il 2025.
La Giunta regionale ha adottato una delibera fondamentale sulle modalità di finanziamento dei servizi per anziani per l'anno 2025, destinati a beneficiare le Unités...
- Pubblicità -

Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.