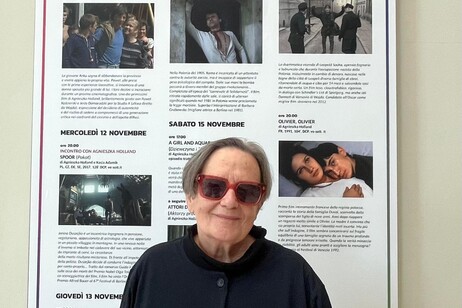L’utopia di un’era digitale democratica, promessa da Internet e dalle piattaforme sociali, si è infranta contro una realtà ben più complessa e inquietante.
Invece di colmare il divario tra privilegiati e marginalizzati, il web sembra aver amplificato le divisioni, alimentando un clima di paura e di odio, come lucidamente osservato dalla regista Agnieszka Holland.
Il suo sguardo, acuto e profondamente umano, si proietta sull’attualità da un percorso artistico costellato di opere coraggiose che hanno affrontato le ferite più profonde della storia europea, dalla Shoah (“Europa Europa”) alle drammatiche condizioni dei migranti al confine bielorusso-polacco, immortalate in “Green Border”, vincitore a Venezia.
L’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, in particolare l’intelligenza artificiale, rappresenta un punto di svolta potenzialmente catastrofico per le fondamenta stesse della democrazia.
La propaganda hitleriana, basata su mezzi relativamente rudimentali come immagini, stampa e radio, appariva già allora pervasiva ed efficace; oggi, con la miriade di canali e strumenti a disposizione, la manipolazione dell’opinione pubblica raggiunge livelli senza precedenti, facilitando la diffusione di notizie false e discorsi d’odio in un panorama mediatico apparentemente incontrollabile.
Il controllo dell’informazione non è più appannaggio esclusivo di governi autoritari, ma è frammentato e disperso tra autocrati, potenti aziende tecnologiche e oligarchi, che esercitano un’influenza capillare sulla vita dei cittadini.
Questa situazione, aggravata da una crisi europea di profonda portata, è in parte figlia di una lentezza reattiva, di una mancata comprensione della velocità con cui il progresso tecnologico sta trasformando il tessuto sociale.
Nonostante questo scenario desolante, il cinema mantiene un ruolo cruciale come forma d’arte capace di illuminare il mondo e di offrire uno sguardo penetrante sull’animo umano.
Tuttavia, la sua integrità è sempre più compromessa dalla crescente influenza del denaro, che corrompe i creativi e limita la libertà espressiva.
Sebbene i documentari si impegnino a denunciare le problematiche più urgenti, essi faticano a raggiungere un impatto globale paragonabile a quello del cinema di finzione o delle serie televisive.
Anche queste ultime, però, sono pesantemente condizionate da interessi privati, finanziamenti pubblici e dalla volontà di evitare contenuti controversi o provocatori.
In questo contesto, la capacità del cinema di sfidare il potere e di promuovere il cambiamento si trova sempre più a rischio, soffocata da una rete di pressioni economiche e politiche.
Il futuro della narrazione, e con essa la possibilità di una coscienza collettiva informata e critica, appare incerto.