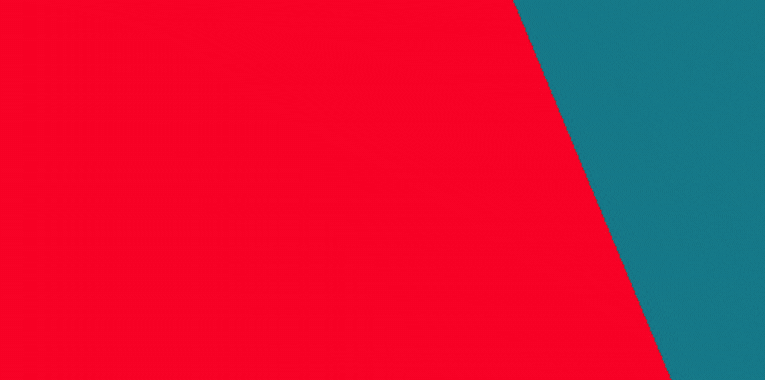L’era contemporanea, segnata da conflitti sempre più frequenti e pervasivi, solleva un interrogativo cruciale: stiamo banalizzando la guerra? L’osservazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la presentazione del suo libro “Un’altra storia”, riflette una preoccupazione diffusa e profondamente radicata.
Il pericolo non risiede semplicemente nella frequenza delle ostilità, ma nella progressiva accettazione, quasi naturale, della guerra come uno strumento di risoluzione delle controversie, un’alternativa – e forse, agli occhi di alcuni, una soluzione più rapida – alla complessità del dialogo politico e della democrazia deliberativa.
La “sdoganazione” della guerra, come la definisce Landini, implica un pericoloso spostamento di paradigma.
Storicamente, la guerra era considerata l’ultima *ratio*, l’estremo rimedio a cui ricorrere solo quando ogni altra via di comunicazione e negoziazione si fosse rivelata impossibile.
La sua legittimazione implicita, la sua normalizzazione nel discorso pubblico, rischia di erodere il valore intrinseco della politica, intesa come arte del possibile, come compromesso tra interessi diversi, come costruzione condivisa di un futuro comune.
Quando la guerra viene presentata come una soluzione pragmatica, un mezzo per raggiungere obiettivi strategici, si offuscano le sue conseguenze devastanti: la perdita di vite umane, la distruzione di infrastrutture, la frammentazione sociale, le crisi economiche, i traumi psicologici che si trasmettono di generazione in generazione.
Si dimentica che la guerra non è un gioco a somma zero, dove un vincitore celebra la vittoria mentre l’avversario subisce la sconfitta.
È una tragedia collettiva che lascia cicatrici profonde e durature, spesso in modo irreversibile.
Inoltre, la tendenza a considerare la guerra come un’opzione legittima alimenta un circolo vizioso: la preparazione militare diventa una priorità, gli investimenti in armamenti aumentano, le tensioni internazionali si esacerbano, e il rischio di escalation diventa sempre più concreto.
Questo processo, alimentato da narrazioni spesso semplificate e ideologizzate, distoglie risorse preziose che potrebbero essere impiegate in settori cruciali come l’istruzione, la sanità, la ricerca scientifica e lo sviluppo sostenibile.
La democrazia, nella sua essenza, si basa sul principio del dialogo, del confronto pacifico, della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che riguardano la collettività.
La guerra, al contrario, è una negazione di questi principi.
Quando la guerra sostituisce la politica, si assiste a un indebolimento delle istituzioni democratiche, a una compressione delle libertà civili, a un aumento del potere esecutivo a scapito del potere legislativo e giudiziario.
Riaffermare il valore della politica, rafforzare le istituzioni democratiche, promuovere la cultura della pace e della cooperazione internazionale sono imperativi urgenti.
Questo richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori sociali: governi, organizzazioni internazionali, associazioni della società civile, movimenti per i diritti umani, cittadini consapevoli.
È necessario riscoprire l’importanza del multilateralismo, rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite, promuovere la diplomazia preventiva, investire nell’educazione alla pace e alla non-violenza.
In definitiva, la “sdoganazione” della guerra non è semplicemente un problema politico, ma un problema culturale, etico e morale.
Richiede un profondo ripensamento dei nostri valori, delle nostre priorità, del nostro modo di intendere il futuro dell’umanità.
La guerra non è una soluzione, ma un fallimento.