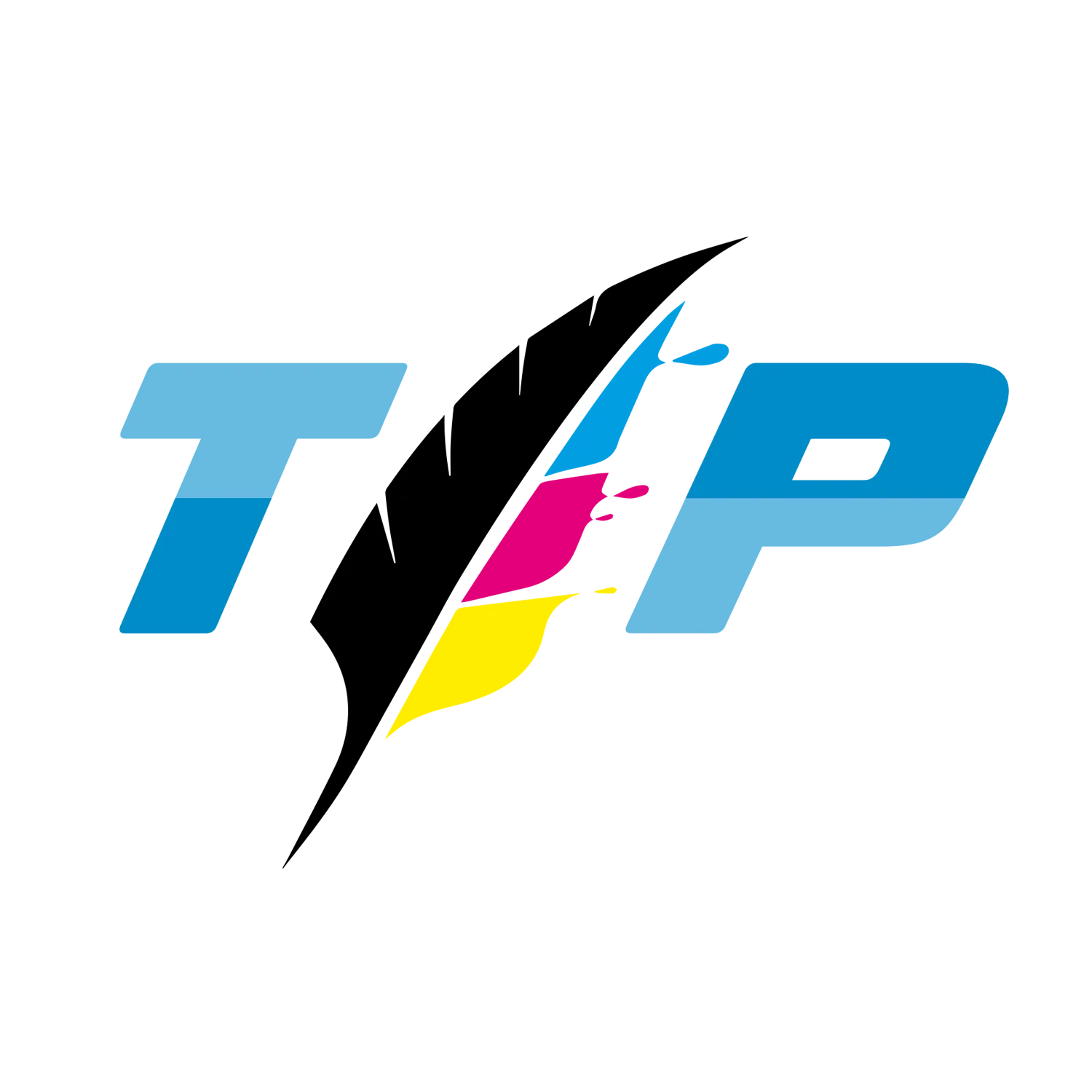“Commedia divina” di Ali Asgari si configura come un’opera stratificata, un atto d’accusa velato di umorismo corrosivo contro le costrizioni di un regime.
Più che un semplice film, è una riflessione metacinematografica che esplora il rapporto tra arte, potere e identità in un Iran soffocato dalla censura.
Asgari, già noto per “La bambina segreta” e “Kafka a Teheran”, dipinge il ritratto di Bahram (interpretato da Bahman Ark), un cineasta intrappolato in una spirale di rifiuti ministeriali.
Bahram è un personaggio complesso, un caleidoscopio di influenze artistiche che richiamano Woody Allen, Nanni Moretti e Buster Keaton, un uomo che aspira alla creazione e alla condivisione della sua opera, ma è ostacolato da un sistema che nega la sua voce.
Il film si sviluppa attorno a un dialogo kafkiano, un confronto surreale con un funzionario del Ministero della Cultura, incarna le rigidità di un’etica islamica interpretata in chiave repressiva.
Ogni elemento del film, persino la presenza di un animale, viene scrutinato e giudicato in base a criteri incomprensibili e arbitrari.
La decisione finale, l’etichetta di “indecenza”, sancisce l’impossibilità di esprimersi liberamente, ma Bahram, animato da una fierezza testarda, rifiuta di arrendersi.
In un percorso alla ricerca di una via d’uscita, Bahram si avvale dell’aiuto inaspettato della sua giovane produttrice, Sadaf (Sadaf Asgari), un personaggio dinamico e ribelle, la cui apparente fragilità nasconde una forza interiore notevole.
Il loro viaggio, a bordo di una Vespa rosa, diventa una metafora del desiderio di evasione e di speranza.
Incontrano attori vanitosi, registi compromessi con il sistema, e una ricca borghese teheranina, ognuno a modo suo rappresentante delle contraddizioni della società iraniana.
L’impianto visivo e sonoro è intriso di citazioni cinefile, omaggi a maestri come Godard e a sonorità jazz che evocano l’estetica di Woody Allen, creando un’atmosfera che oscilla tra il tragico e il comico.
La staticità delle inquadrature, lunghe e contemplative, riflette l’immobilità del sistema, l’inerzia di una burocrazia che soffoca ogni tentativo di cambiamento.
L’umorismo, elemento centrale del film, non è una semplice soluzione comica, ma una strategia di resistenza.
Di fronte alla repressione, il riso diventa un atto di sfida, un modo per preservare la propria umanità e per denunciare l’assurdità del potere.
I personaggi affrontano le ingiustizie con un sarcasmo silenzioso, con una consapevolezza amara che trasforma la frustrazione in resilienza.
La frase “Voglio proiettare il mio film per diventare umano” si rivela la chiave di volta dell’opera.
Non si tratta semplicemente di ottenere il permesso di esporre un’opera d’arte, ma di affermare la propria esistenza, di reclamare il diritto di essere riconosciuti come individui pensanti e sententi.
Realizzare “Commedia divina” è un atto di coraggio, una dichiarazione di speranza che trascende i confini geografici e politici, invitando lo spettatore a riflettere sul potere dell’arte come strumento di libertà e di resistenza.
Il film è, in definitiva, un inno alla dignità umana, capace di risuonare con forza in ogni luogo in cui la voce viene messa a tacere.