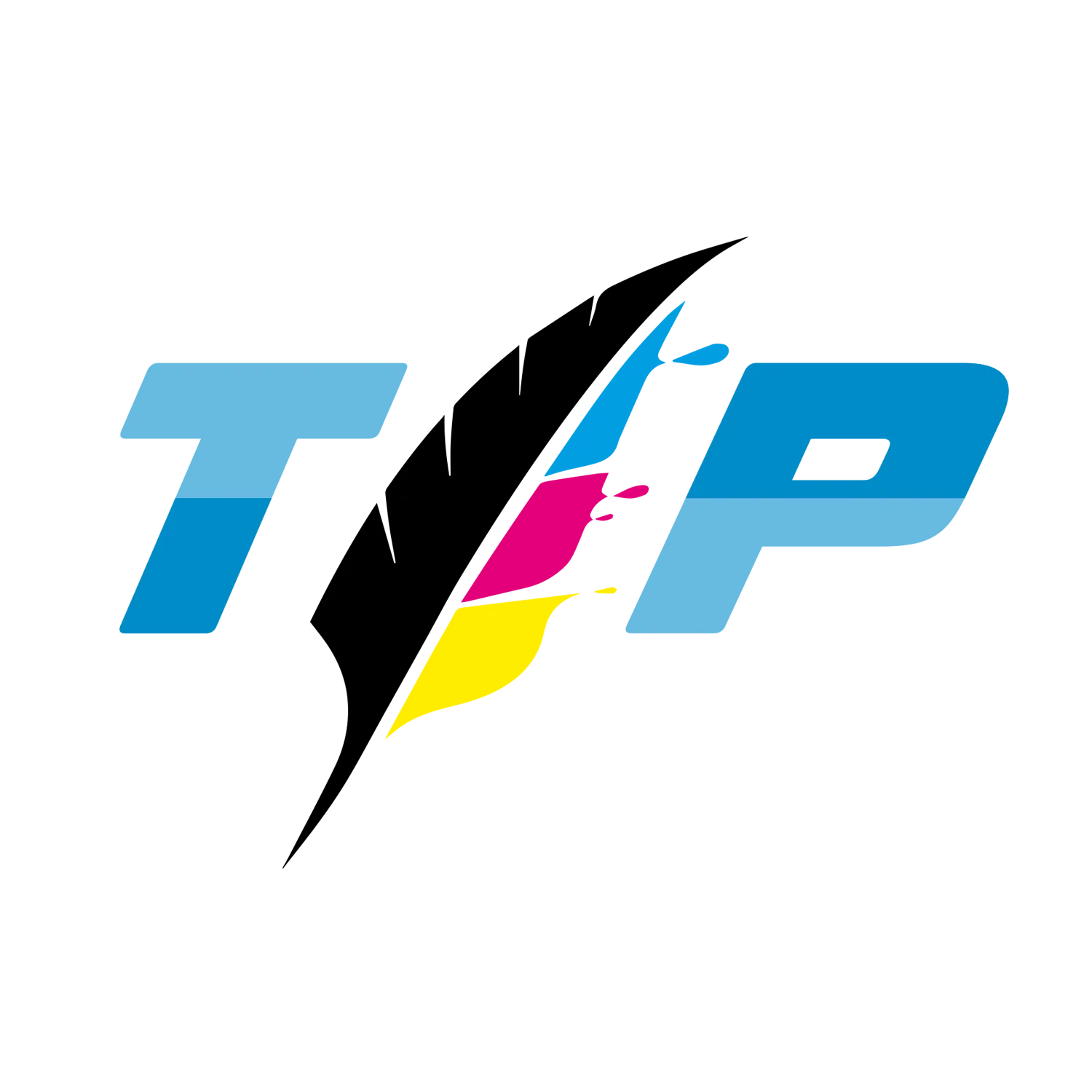La presunzione di unicità, l’arroganza cosmica di immaginare che l’umanità regni sovrana nell’immensità del cosmo, cela una profonda, e forse inconsca, difficoltà ad accettare la propria finitudine.
L’affermazione di Emma Stone, scherzosa ma rivelatrice, sul suo possibile essere aliena, risuona come un’eco di questa vertigine esistenziale.
La sua battuta, tratta dal contesto del remake veneziano di “Bugonia”, ispirato al geniale film sudcoreano “Save the Green Planet!”, introduce un tema centrale: la nostra incapacità, o più probabilmente la nostra riluttanza, ad abbracciare la possibilità di non essere soli.
“Bugonia”, come il suo predecessore, esplora con acume satirico e humour surreale l’ossessione per il mistero, il complotto, il “diverso”.
I protagonisti, Teddy e Don, due figure archetipiche del nerd, inglobati in un labirinto di teorie cospirative, incarnano la paura dell’ignoto, proiettando le loro ansie su un bersaglio emblematico: un’influente CEO farmaceutica, accusata di essere un’aliena infiltrata con l’obiettivo di annientare il pianeta.
Questa rappresentazione, grottesca e al contempo profondamente umana, solleva interrogativi cruciali sulla natura della percezione, la costruzione della realtà e la nostra tendenza a demonizzare ciò che non comprendiamo.
Il film, diretto da Yorgos Lanthimos, si inserisce in un filone cinematografico che, partendo dalla fantascienza, si interroga sulle dinamiche del potere, la manipolazione sociale e la crisi di identità nell’era digitale.
L’idea di un’aliena che si nasconde tra noi, sfruttando la nostra fiducia e la nostra ingenuità, non è altro che una metafora della nostra vulnerabilità, della nostra incapacità di distinguere la verità dalla menzogna, la realtà dall’illusione.
L’intervista a Emma Stone, che collabora per la quarta volta con Lanthimos, rivela un ulteriore livello di complessità.
L’attrice affronta il tema della celebrità, la difficoltà di conciliare l’immagine pubblica, l’avatar costruito attorno alla figura dell’attore, con la persona reale, privata, che si manifesta solo in contesti intimi.
Questa dicotomia, questa scissione tra “persona pubblica” e “io autentico”, è una costante nella vita delle star, ma risuona in tutti noi.
Costruiamo maschere, recitiamo ruoli, ci presentiamo in modi diversi a seconda del contesto sociale.
La difficoltà di essere se stessi, di esprimere la propria vulnerabilità, è una sfida universale.
Il riferimento al film “Jay Kelly” di Baumbach, con George Clooney, sottolinea la pervasività di questo tema.
La celebrità, il successo, il riconoscimento pubblico, sono spesso accompagnati da un senso di alienazione, da una perdita di contatto con la propria identità.
L’avatar, la maschera, diventano una protezione, un rifugio dalla pressione del mondo esterno, ma allo stesso tempo imprigionano l’individuo, lo separano dalla sua vera essenza.
Forse, la consapevolezza di poter essere “alieni”, nel senso più ampio del termine, di esseri diversi, estranei a un sistema che ci definisce, è la chiave per liberarci dalle nostre catene, per accettare la nostra complessità, per abbracciare la possibilità di un’esistenza più autentica.
La presunta solitudine cosmica è un’illusione.
Siamo tutti connessi, tutti parte di un universo sconfinato e misterioso, e la vera sfida è imparare a convivere con questa verità.